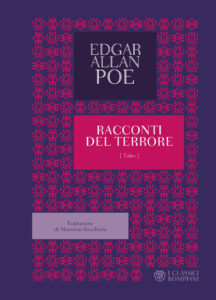 Misterioso è l’incoscio che ci parla attraverso la dimensione onirica, per simboli, per immagini, mediante una metaforizzazione ininterrotta di figure che, diurnamente, divengono degli emblemi che si sedimentano in noi e che, magari, ci paiono irrilevanti, mentre influenzano il nostro essere e il nostro divenire.
Misterioso è l’incoscio che ci parla attraverso la dimensione onirica, per simboli, per immagini, mediante una metaforizzazione ininterrotta di figure che, diurnamente, divengono degli emblemi che si sedimentano in noi e che, magari, ci paiono irrilevanti, mentre influenzano il nostro essere e il nostro divenire.
Là, in una profondità remota ed apparentemente ignota del nostro essere noi stessi che, consciamente, spesso finiamo per non essere davvero, rifiutandoci in quanto espressione di veri desideri, reprimendo le nostre passioni per obbedire alle consuetudini e alla bontà dei sentimenti riconosciuti dal “senso comune“, laggù si staglia contro l’incoscienza vigile tutto un distopico turbinio di ologrammi.
I sogni a volte sono incomprensibili, perché cerchiamo sempre, ossessivamente delle certezze e queste stanno ostinatamente abbarbicate ad un “senso” delle cose che è proprio dell’io cosciente. Non dell’inconscio che, tuttavia, ha un suo modo di esprimersi attraverso le immagini. L’associazione delle stravaganze non è insensatezza. E’ quello che ci abita e che non emerge alla superficie. Ma non per questo deve essere reputato come alieno dalla realtà.
Anzi è la nostra realtà più profonda, la nostra essenza più vera. Se per “vero” vogliamo intendere il nocciolo da cui si sviluppa la pianta. Dunque, nel buio della notte, nell’abbandono, nel mancare e venire meno di noi stessi, prendono vita sempre i noi quelle immagini che possono anche assumere le sembianze di incubi. Il terrore fa, del resto, parte delle nostre emozioni. La paura è qualcosa che attiene all’oggettivo, al reale. La fobia no. La forma fobica è una traduzione nevrotica della paura. E’ andare nell’al di là della paura stessa.
Il terrore è, quindi, nel possibile, perché si riferisce al timore estremissimo che qualcosa di orribile ci possa capitare e, nel peggiore dei casi, ci annienti. La morte dovrebbe essere la punta più aguzza di una lancia che sospinge il nostro timore a diventare esponenziale, a non fermarsi davanti alla razionalità e all’oggettività dell’esistenza. Sappiamo che dobbiamo, prima o poi, cessare di vivere. Ciò che non sappiamo è quando questo accadrà. Il mistero, pertanto, è insieme croce e delizia: la prima, perché ci condanna alla conturbante inconsapevolezza del “quando“; la seconda perché ci coccola con una inconoscibilità palliativamente allietante.
Ma l’incubo notturno, quello che ti fa svegliare di soprassalto, sudaticcio e in preda al cardiopalma, pare averti detto che il sogno era talmente reale da sembrarti tale. E nell’essere oltretutto davvero poco piacevole, l’angoscia ti ha avvinghiato, ti ha fatto trasalire e ti ha sprofondato in una percezione di una sofferenza tutta immaginaria che ottiene il suo scopo nel momento in cui invece mostra il suo epifenomeno di finzione del reale.
Edgar Allan Poe racconterà i suoi sogni, di una infanzia priva di genitori, di un amore coniugale da favola che finisce nella miseria materiale più nera, mentre il piccolo cresce e si fa bello probabilmente come la madre. Una attrice per cui suo padre perde la testa, rinnega la precedente agiatezza e si inventa pure lui nello stesso mestiere della moglie. Con la morte dei genitori, si affaccia nella vita del giovanissimo Edgar il dramma della solitudine.
Sarà un incubo ricorrente: il bussare e il bussare ancora, nelle tante porte chiuse che scorge nei suoi sogni. Dall’altra parte sente parlare, ma non c’è nessuno che gli apra. Eppure il ragazzo ascolta le voci, le ode distintamente e le riconosce. Ma niente. Il sogno si ripete, l’angoscia aumenta e la solitudine diviene, paradossalmente, una delle sue compagne di vita; insieme all’alcool e all’insoddisfazione. Ogni tanto quest’ultima segna il passo e lascia prendere il sopravvento al talento da scrittore di un ragazzo che dimostra sin dai primi studi una vivida intelligenza.
Intuizione, capacità mnemonica, fantasia che si espande e che tutto include, comprende; che non tralascia nulla delle bellezze e degli orrori della vita. Poe travisa sé stesso a lungo, quando si getta nei fumi del gin, quando ne scrive parafrasandosi nei “Racconti del terrore” (Bompiani, 2022), così come in quelli del mistero e dell’incubo. Lui non è l’iniziatore, il padre di un genere letterario nuovo. Semmai ne è il geniale amplificatore. Altri prima di lui si erano cimentati nei racconti tenebrosi ed orrorifici.
Lui, però, è quel (parzialmente) incompreso dalla critica dell’epoca che spalanca le porte al fantasy non favolistico, al racconto breve in cui in prima persona il narratore finisce col prendersi l’anima e la mente del lettore per farne un tutt’uno con sé stesso. Non c’è l’autore che racconta il soggetto al suo pubblico. C’è soltanto il soggetto e colui che sta al di qua delle pagine. Tutti sono concordi nell’affermare, ammiratori, cultori e semplicissimi viandanti nei libri di Poe, che dalla prima riga all’ultima di un racconto non c’è sosta.
Non ti puoi fermare. Devi leggere, leggere e continuare a leggere fino alla fine. La scrittura è così variegata da non poter essere imbrigliata in un unico categorico stile. Ma un tratto distintivo e comune tra tutti i racconti c’è: il pathos che aumenta di pari passo all’accrescersi del mistero. Sembra di essere sempre ad un passo dall’aver compreso ciò che sarà il finale, ed invece lo stupore la fa da padrone e vince la partita.
Per chi negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso ha visto in televisione “L’ora di Hitchcock” oppure “Ai confini della realtà“, le opere di Poe sembreranno un ante litteram senza alcuna ombra di dubbio. O, per meglio dire, il maestro ha ispirato gli allievi novecenteschi che sono stati, a loro volta, dei giganti del giallo, del nero, del cupo, del velato dalla nebbia, dell’intravedere la soluzione, del lasciarsi dondolare dalla fantasia e da quella suspence che è il tocco di versatilità che una narrazione assume quando è capace di incantare e disincantare al tempo stesso il lettore o lo spettatore.
La descrizione dell’ambiguità umana, dello scivolare nel torbido più retrivo dei peggiori sentimenti, di quell’odio che è umanoide in tutto e per tutto, corre velocissima su un piano di sceneggiatura che spazia dal fantastico al mefistofelico, dal materiale e concreto al metafisico e magico. Occultismo, paranormale ed ectoplasmatiche percezioni si susseguono tra gli occhi luccicanti di un gatto, le mura cadenti di una casa, il terrore delle sepolture premature…
Poe agita non solo le coscienze; soprattutto gli animi. Coinvolge al punto da immedesimare e qui, proprio qui, sta tutta la potenza del suo raccontare nella rigorosa prima persona dei protagonisti-vittime. Violenza, crudeltà, tortura, omicidi fanno il paio con il candore di certe emozioni che ne sono il contraltare e stabiliscono quel rapporto di ambivalenza che giace nel profondo umano e che viene riconosciuto come esclusività della nostra specie.
Amore e morte si intrecciano, come nelle più classiche tragedie antiche e come nei racconti cavallereschi medievali. Oltre alla molteplicità degli stili di scrittura, di quelli di una narrazione davvero sorprendente, Poe ci regala una galassia di personaggi veramente dei più diversi. Collocati in tempi altrettanto lontani fra loro ma che, alla fine, si possono riconoscere tutti quanti in un grande teatro di un assurdo che è, invece, la rappresentazione delle inconfessabilità tanto verso noi stessi quanto verso gli altri.
Cadaveri e putridumi divengono familiari in una carrellata di trapassi che, tuttavia, per quanto prevalenti possano sembrare nei confronti della gioia e del senso dell’esistenza, non prevalgono mai sulla considerazione della vita come di un bene troppe volte sciupato, vilipeso, deriso e mortificato da tante azioni in cui pensiamo di risolvere i problemi di ogni giorno e che, invece, ci lasciano solo amaro in bocca, il vuoto intorno e quel senso di solitudine che non abbandona mai l’autore.
Nel corso della sua di vita, Poe non fu un tipo schivo e antisociale come tendono a descriverlo critici e ipercritici che hanno tratto dai suoi racconti più dei pregiudizi che dei giudizi. Aveva amici, aveva amori, aveva sentimenti profondamente umani e, per questo, per niente esclusivi; negletti tanto quanto possono esserlo i nostri. Il ricorso allo stordimento e all’oblio alcolico non sarà mai un pretesto inconsapevole. La sua coscienza, il suo essere veramente cosciente di una dipendenza, da liquori surrogato di affetti mai avuti completamente, gli saranno sempre ben note.
Poe non è un antisociale. E’ un anticonformista. Rigetta le convenzioni e non distingue in base al ceto, alla ricchezza o alla povertà. La sua esistenza sarà un alternarsi tra lunghe lucidità e altrettanto lunghi momenti di apatia, di separazione dal reale per sopportare il reale stesso. Nello scrivere si rigenera perché si espone in prima persona in una autoanalisi che vuole formulare seguendo il rito metaforico del racconto.
E’ stata proprio l’intransigenza di una scuola letteraria transcontinentale, tutta protesa al moralismo della coincidenza tra opera e vita privata, tra, in questo caso, il Poe scrittore e l’Edgar fanciullo che si trascina appresso i problemi esistenziali dall’infanzia all’adolescenza, da questa alla maturità di un quarantenne che muore dopo l’ultima bevuta. Si accascia al suolo; non lo riconosce nessuno. Lo portano in ospedale a Baltimora e solo dopo morto si rendono conto che in quel letto stava, ormai senza più vita, uno dei più grandi scrittori americani dell’Ottocento.
Sembra una nemesi vero? Chi mai però la immaginerebbe contro un giovane uomo che ha scavato nell’animo umano e ha fatto della psicoanalisi prima della psicoanalisi stessa, che ha fatto dell’horror e del giallo prima che questi generi contagiassero le fantasie di miliardi di persone nel mondo? Nemmeno la vendetta dello Storia può essere così cinica e bara, tanto da costringere il maestro del terrore e dell’incubo, del mistero e dell’orrore a vivere la sua fine come se si trattasse di un racconto nei suoi racconti.
Un sogno da svegli, un incubo ad occhi aperti. Un po’ come ne “Il Mago di Oz“, un po’ come in quei film dove il protagonista scopra che, non tanto la fiaba, ma la trama pressante termina con la delusione più cocente: era tutto un fantasticare… No, Edgar Allan Poe non ci inganna fino a questo punto: ci descrive come siamo. Abietti e capaci al tempo stesso di nobilissimi slanci sentimentali.
In un universo distopico, sì, potremmo affermare che i racconti di Poe sono il proscenio del finale mai scritto: quello della sua esistenza. Impossibile da redigere perché l’autore, semplicemente, non c’è più. Sono la storia infinita che torna e ritorna, nell’eterno ritorno un po’ nietzschiano di un proseguimento di sé stessi affidato non al caso delle molteplici ed infinite combinazioni offerte dall’esistente materia che si compone e scompone, ma da ciò che si lascia.
Il racconto di sé stesso nei racconti di figure che impressionano al punto da sentirsi partecipi delle loro angosce, delle loro turbe psichiche e dei loro dolori fisici. C’è un po’ di Poe in tutti noi. Quando lo si è letto, non si può che convenirne.
I RACCONTI DEL TERRORE
EDGAR ALLAN POE
BOMPIANI, 2022
€ 13,00
MARCO SFERINI
24 aprile 2024
foto: screenshot ed elaborazione propria
Leggi anche:













