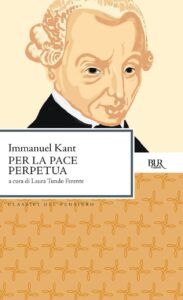 Antica domanda, che molti filosofi si sono posti e a cui non sono riusciti a dare una risposta certa e definitiva, è quella se qualcosa operi nella società per indirizzare la stessa verso un fine determinato; oppure se, al posto dell’ipotesi, per l’appunto detta “deterministica“, siano le congiunture, le sovrapposizioni e le complesse interazioni di tante coscienze, culture, aspetti dell’etica e della materialità, tra metafisica e sostanza concreta dell’essere e dell’agire, a fare del conglomerato umano un motore autosufficiente ma senza una precisa direzione da seguire e un preciso punto all’orizzonte cui tendere e arrivare.
Antica domanda, che molti filosofi si sono posti e a cui non sono riusciti a dare una risposta certa e definitiva, è quella se qualcosa operi nella società per indirizzare la stessa verso un fine determinato; oppure se, al posto dell’ipotesi, per l’appunto detta “deterministica“, siano le congiunture, le sovrapposizioni e le complesse interazioni di tante coscienze, culture, aspetti dell’etica e della materialità, tra metafisica e sostanza concreta dell’essere e dell’agire, a fare del conglomerato umano un motore autosufficiente ma senza una precisa direzione da seguire e un preciso punto all’orizzonte cui tendere e arrivare.
La filosofia, per lungo tempo, ha cercato una coniugabilità tra trascendenza religiosa e immanenza del reale, del quotidiano: un ponte razionale, o comunque legato ad una sorta di costruzione logica, tra volontà divina ed esperienza umana. In fondo, affermare che la vita sulla Terra, che la Terra stessa e che l’Universo sono frutto di una creazione dogmaticamente imperscrutabile, di una volontà che esula dalla condizione stessa dei creati, era fino a non molto tempo fa un assunto che aveva bisogno di un substrato giustificazionistico.
Come era pensabile ritenere che l’umanità, dotata del “libero arbitrio“, si allontanasse sempre più dai precetti evangelici, scannandosi, riducendosi a mercenaria di sé stessa e contro sé stessa,a servitrice del potere e che, per giunta, la Chiesa stessa, portatrice, perché prima ed esclusiva interprete del messaggio divino (e del divino stesso…), arrivando quindi quasi a sconfessare la missione primordiale del Creatore medesimo, ossia quella di una esistenza fondata sull’amore, sulla reciproca condivisione di sentimenti e di atti pratici e concreti legati alla quotidianità di un tempo calato nel micromondo, al di sotto della sfera celeste?
La contraddizione tra origine benevola della natura delle cose e perversione successiva era ed è rimasto a lungo un piano inclinato verso una dicotomia inspiegabile, se non con il riferirsi alla disobbedienza da parte dell’essere umano nei confronti di Dio stesso: a partire dalla metafora mitologica dell’Eden paradisiaco, di Adamo, di Eva e del serpente tentatore.
Ma, seppure le favole siano piacevoli da leggere, questa spiegazione semplicistica non poteva soddisfare né i padri della Chiesa e né tanto meno i filosofi che sarebbero venuti dopo. Anche molto tempo dopo una scolastica e una patristica che, nonostante tutto, una spiegazione tra imponderabile divino e inspiegabile umano, avevano tentato di darla.
Senza prescindere dall’ “ipotesi Dio“, ben presente nella tradizione e nella stretta attualità della vita di molti pensatori del passato, costretti a fare i conti con il potere della Chiesa cattolica e, in generale, delle religioni strutturatesi in veri e propri strumenti della gestione tanto degli Stati quanto delle vite dei popoli dalle grandi città alle campagne, il criticismo kantiano rompe questa gabbia tutta teleologica dove il finalismo comprende in sé la ragione umana ma, allo stesso tempo, finisce col mortificarla, subordinandola alla sola volontà divina.
Invece, per la prima volta nella storia della filosofia occidentale, Immanuel Kant introduce il giudizio come elemento conoscitivo e, quindi, già di per sé rema contro l’impassibilità dogmatica, il muro della religiosità come fenomeno inattraversabile, a cui fare comunque riferimento nel processo gnoseologico, nel tentativo del tutto razionale e fattuale di fare passi avanti nella conoscenza reciproca, nell’apprendere sempre meglio le dinamiche dialettiche che danno corso all’evoluzione sociale, morale, civile, culturale dell’umanità intera.
Prescindendo da un materialismo storico che Kant, per ovvie ragioni, non poteva conoscere e a cui, del resto, non pensa di fare riferimento nella sua analisi critica tanto della ragione quanto nell’adesione ad una metafisica che prescinde dalla declinazione deistica del passato e che, per il filosofo di Königsberg (oggi Kaliningrad), diviene un punto di incontro tra la credenza in Dio (e non, dunque, la ricerca della dimostrazione della sua esistenza) e la realtà della natura, della scienza, delle arti, dei saperi in generale.
La ricerca di un metodo, o per meglio dire di una interpretazione delle azioni umane, che ci facciano strumento di azione “Per la pace perpetua” (a cura di Laura Tundo Ferente, edizioni BUR, Rizzoli, 1968, 20o3), è senza ombra di dubbio affidata ad una indagine antropologico-sociologica ma, prima ancora è una parte di quella costruzione etica che Kant mette avanti come elemento fondante di un apprendimento più vasto, di una maggiore consapevolezza se non del tutto, quanto meno dei fattori che muovono la società nel contesto di una natura che la metafisica da sola non spiega.
Certe determinazioni aprioristiche, tipiche del criticismo di Kant, sono quel substrato trascendentale che non scompare mai completamente nell’analisi a-religiosa di un filosofo che, comunque, come è già emerso, crede in Dio ma non al punto da farlo diventare un instrumentum regni o, peggio ancora, un ostacolo nei confronti delle scienze e dell’apprendimento nel riferimento più genuino all’etimologia del termine: entrare in possesso di un qualcosa che, nel nostro caso, può essere un bene comune.
Cos’è, dunque, si domanda Kant, che rende gli esseri umani così ferocemente avversari gli uni rispetto agli altri? Da dove nasce questa litigiosità esponenziale, che spinge alle guerre, che mette popoli contro altri popoli, che fa del mondo un enorme contesa globale dove i principi, i re, gli imperatori, le repubbliche oligarchiche e persino le più piccole comunità auto-organizzate si fronteggiano per, almeno all’apparire, avere un dominio superiore ad altri e, quindi, sembrare di dover vivere a scapito di altri?
La risposta non è univoca e nemmeno trova un esaustivo confronto con tutte le sfaccettature della contestualità o del passato, se si scorre il cammino umano in un più lungo corso degli eventi. Kant riconosce che la Natura (enne maiucola) predestina in qualche modo la vita degli esseri umani (e non solo di loro) sull’intero globo. Li “costringe” a vivere ovunque, in condizioni a volte più semplici, altre volte di vera e propria resistenza continua contro la furia degli elementi. Di qui una forma di adattamento che i popoli sviluppano fino a che gli è possibile. Altrimenti emigrano.
Anche da questi fenomeni migratori – osserva il filosofo tedesco – nascono le guerre, i conflitti, perché la condivisione degli spazi è oggetto di contesa e sembra che «il coraggio guerresco (tanto presso i selvaggi americani quanto presso gli europei al tempo della cavalleria) è ritenuto di inestimabile valore non solo in caso di guerra (come è giusto), ma anche in quanto spinge alla guerra, e spesso a intraprenderla soltanto per farne mostra. Perciò alla guera in sé stessa è annessa una dignità intrinseca» tando da dimenticare, chiosa Kant, l’antico detto ellenico: «La guerra è un male, perché produce più malvagi di quanti non ne distrugga».
Dunque, assodato – o quasi – che la guerra è un elemento costituente di una umanità che tende istintivamente allo scontro, alla bellicosità, Kant si rifà al diritto come al regolatore di una moralità più alta, da ricercare e da stabilire in quanto nuovo fondamento etico universale di una società che può dominare un istinto naturale annichilente. L’oggettivià della guerre come fenomeno tipicamente umano (ed anche animale, proprio in quanto umano), non deve essere un alibi per i popoli, ma deve anzi diventare il presupposto per un suo superamento.
Ragione e diritto sono gli strumenti da adoperare per garantire un giorno la fondazione della “pace perpetua“. L’egoismo ancestrale può essere superato, in virtù dell’utilizzo del e nel confronto razionale di uno sviluppo dialettico propositivo e, quindi, condiviso e costituente un precetto di Legge generale che permetta alla società di regolarsi su un piano esattamente opposto a quello del passato.
Kant, esponente primo di un criticismo moderno che non tiene conto dei rapporti di forza materiali, della struttura economica di una società che non dipende, quindi, esclusivamente dalla buona volontà del singolo o del collettivo umano, si affida ad un processo interpretativo sovrastrutturale che, tuttavia, ha la sua logicità proprio nel mettere insieme tutte le buone ragioni che condurrebbero anche ad una “utilità” manifesta per quel potere che, alla fine, domina e organizza, reprime e disarticola, distrugge e rimette insieme i cocci di esistenze devastate.
Per Kant la Natura è la migliore organizzatrice della divisione sulla Terra dei popoli. Il potere corrompe questa naturalità delle separazioni nella convivenza universale. Lo fa sopraffando nel nome dell’estensione della propria autorità, della ragione tanto di Stato quanto di una tradizione religiosa o etica che si fa ritenere superiore ad altre. Quello che il filosofo di Königsberg chiama lo “spirito commerciale” è, in fin dei conti, la considerazione di un aspetto che emerge in tutto questo ragionare in punta di legge, diritto ed etica.
Kant si rende conto che gli interessi economici forniscono le ragioni maggiori per affermare la schiettezza brutale del denaro come interesse primario per garantire una ipocritissima “felicità comune“. La pace viene negata ogni volta che gli Stati si confrontano proprio a causa della “forza” di una economia rispetto ad un’altra e il potere che si conquista non lo si cede tanto al proprio popolo quanto ad altri regnanti o presidenti. Chiunque prevale e conquista lo fa con l’imperativo di essere il detentore assoluto di un diritto che si è preso e che non è, invece, sorto da un confronto, da una reciprocità di intenti.
La “legge morale” non può, quindi, risiedere nell’esercizio di un potere che prescinde dalla felicità dell’umanità e dal tentativo di instaurare governi che prevedano anzitutto il maggiore avvicinamento possibile ai fondamenti naturali a riguardo della vita e della convivenza tra i popoli. E’ quello che Kant sintetizza nel concetto di “politico morale” (che è ben altro da quel moralismo politico che lui invece disprezza, perché giudicante, irriverente, presuntuosamente spocchioso).
Il politico morale è colui pronto a correggere le storture dell’organizzazione statale, del diritto interno come di quello cosmopolitico; è colui che si produce nella più attenta e costante relazione tra interesse sociale e interesse singolare e che, nell’operare in questo modo, persegue quindi il fine della pace, della stabilità dei bisogni materiali e morali. Kant scrive in merito gli articoli definitivi per l’instaurazione di un tale orizzonte dell’umanità:
«La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio della dipendenza di tutti da un’unica legislazione comune (come sudditi); 3) sulla legge della eguaglianza (come cittadini), è l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, su cui deve essere fondata ogni legislazione giuridica di un popolo; ed è la repubblicana».
La separazione dei poteri è, poi, la discriminante che distingue la repubblica dal resto dei regimi statali, dalle forme che prende l’organizzazione di un popolo (e di un potere) su un determinato territorio. L’arbitrarietà del dispotismo viene, quindi, superata da una concezione illuministica che si richiama ai grandi stravolgimenti in atto proprio in quell’epoca: dalla Rivoluzione americana a quella francese, l’influsso del vento liberatore, della primavera dei popoli sia d’oltreatlantico sia europei, si fa sentire anche negli scritti di Kant.
Gli spunti che “Per la pace perpetua” ci da oggi, in un tempo di guerra anche europea, sono tanti e rimandano ad una visione complessiva della storia del pensiero occidentale in chiave tanto razionale quanto umanistica e ci mostrano un discernimento delle questioni più complesse mediante una semplicità di esposizione che Kant utilizza proprio per arrivare al maggior numero di persone possibili.
Il trattato, o se vogliamo dire il “progetto” che qui viene esposto in termini soprattutto politico-giuridici, deve nutrirsi di una elaborazione anche concettuale che, tuttavia, non significa l’abbandonarsi a speculazioni meramente ipotetiche o visionariamente utopistiche. Kant non scrive per proporre una idea di pace, ma per poterla realmente rendere tale, viva, concreta, realizzabile. Leggerlo oggi è come riprendere in mano il “Dei delitti e delle pene” di Beccaria se si vuole studiare il moderno diritto di ogni Stato che ondeggia in tante contraddizioni tra liberalismo e tolleranza, libertarismo e rieducazione civile.
PER LA PACE PERPETUA
IMMANUEL KANT
BUR, RIZZOLI
€ 9,00
MARCO SFERINI
27 settembre 2023
foto: particolare della copertina del libro
Leggi anche:













